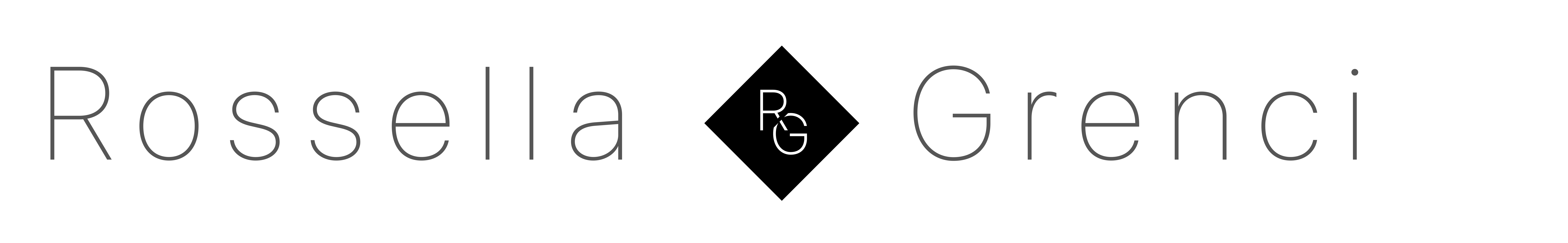Questo mio post vuole essere una risposta all’articolo pubblicato il 31 gennaio su COBAS Scuola dal titolo DSA: i COBAS contro la medicalizzazione degli apprendimenti e la rinuncia alla relazione pedagogica.
Un articolo che mostra quanta confusione vige in materia di DSA nella Scuola italiana. Non solo: da esso emergono tante contraddizioni.
Se dal titolo non potremmo che acconsentire all’impostazione teorica, il riferimento a ricerche scientifiche non prive di letture parziali, fanno altalenare la bilancia alla ricerca di un equilibrio impossibile.
Ma partiamo dal riferimento ai dati pubblicati qualche mese fa, il Focus del Ministero dell’Istruzione per gli anni 2019-2020 e 2020-2021. Come si evince da un’attenta lettura, dal report sugli studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento in Italia risulta che negli ultimi sette anni (dal 2014 al 2021) l’aumento delle certificazioni di DSA è contenuto e si attesta intorno allo 0,1% all’anno, anzi con una riduzione progressiva degli incrementi (che dal precedente report si attestavano allo 0.6%).
Approfondendo l’analisi dei dati si nota inoltre che:
- le certificazioni nella scuola primaria si stabilizzano sostanzialmente attorno al 3%.
- la scuola secondaria di primo grado è quella che mostra un trend crescente ma tendente ad un “soffitto” attorno al 6%.
- Nella scuola secondaria di secondo grado l’aumento delle certificazioni è lineare, con un incremento ogni anno di circa 0.6% (poco più di mezzo punto percentuale).
- il divario Nord-Sud è indizio di una ancora ampia sotto certificazione nelle regioni meridionali.
Le stime epidemiologiche degli altri paesi europei sui DSA si collocano tra il 5% e il 12% e l’ultima revisione del Manuale Diagnostico (DSM V, 2013), ha innalzato le stime di prevalenza di questi disturbi dal 2-10% al 5-15%.
L’approccio “clinico-medico”, come viene da loro chiamato, non è un’invenzione italiana, ma frutto di ricerche scientifiche internazionali che negli ultimi 50 anni hanno aiutato a comprendere un fenomeno che viene definito disturbo, ma che non si riferisce ad alcuna “anomalia”, così come citato nell’articolo in questione.
Si va avanti, cioè, per misurazioni e quantificazioni, trasferendo le “responsabilità” dell’anomalia a cause cliniche e genetiche che finiscono per deresponsabilizzare tutti, i singoli come le istituzioni che non hanno più bisogno di interrogarsi sulle cause delle difficoltà.
Lo studio genetico citato (studio apparso nel novembre scorso sulla rivista Nature Genetics volume 54, dal titolo Discovery of 42 genome-wide significant loci associated with dyslexia) con l’individuazione di ben 42 varianti genetiche legate alla dislessia, conferma la componente ereditaria. L’aver trovato tante varianti con associazioni interessanti con l’ADHD e iperattività e l’ambidestria, per i ricercatori è invece una conferma che queste varianti genetiche comportano un’alterazione del neurosviluppo, che potrebbe influenzare la connettività neurale, cioè il modo in cui i neuroni creano collegamenti fra di loro. Il grande interesse per questo studio è dato dall’altissimo numero di persone dislessiche studiate, convalidando le basi neurobiologiche e le alterazioni genetiche.
Ricorrendo al concetto di “disturbo”, non si deve fare altro, infatti, che rimettersi nelle mani degli “esperti” , eseguendo le indicazioni da loro fornite (o imposte), senza interrogarsi sulle possibili cause “altre”, così come sulle mancanze della scuola, della famiglia, dei docenti, degli stessi studenti: anche se poi sono gli insegnanti ad essere considerati gli unici responsabili delle mancanze dei propri studenti, tra i quali, quando calano le attese sia delle famiglie sia della scuola, si registra la diminuzione sistematica dei livelli di apprendimento.
Laddove ci sono cause che co-occorrono, la diagnosi di DSA sarà il punto di partenza per comprendere la differenza di apprendimento dello studente che il docente si trova davanti. Non si va alla ricerca del “responsabile”, ma del miglior modo per aiutare uno studente che ha bisogno di una didattica che miri a trovare gli strumenti e le modalità per favorirne l’apprendimento. Una didattica che, ampliando gli orizzonti, favorirebbe l’apprendimento di tutti.
In realtà l’articolo non cita il riferimento essenziale che è la legge 170/2010, frutto di una lunga battaglia di civiltà che ha finalmente sancito il diritto ad apprendere degli studenti dislessici.
Il Piano Didattico Personalizzato, previsto dalla legge, lungi dall’essere “la soluzione dei problemi”, è il riconoscimento di un diverso modo di apprendere e delle difficoltà reali dello studente.
Nel mio ultimo saggio LA DISLESSIA. DALLA SCUOLA AL LAVORO NEL TERZO MILLENNIO spiego come il non riconoscimento della dislessia nei primi anni di scuola, o peggio il disconoscimento da parte della scuola e/o dei genitori, espone lo studente a manifestazioni come depressione, sindrome ansiosa, disistima, inibizione emotiva con conseguente abuso di alcol e droghe o comportamenti delinquenziali.
Ecco perché il relativo beneficio è dato dal rafforzamento della fiducia in se stessi che eviti, nel tempo, problematiche psicologiche associate al “trauma” scolastico.
Purtroppo tante ricerche lo hanno evidenziato, la scuola può essere un fattore di rischio per il mancato benessere psico-fisico, qualora una difficoltà di apprendimento non venga riconosciuta. Il senso di impotenza e di frustrazione agisce negativamente sulla psiche di tanti bambini e ragazzi, con ripercussioni anche nell’età adulta.
Quindi, richiamando le conclusioni dell’articolo citato, il problema non è la
medicalizzazione dei processi di apprendimento, rispetto ai quali non si può rispondere con misurazioni, valutazioni, schedature diagnostiche e relative misure compensative e dispensative che non solo non risolvono la questione, ma pongono fittizi paletti di confine tra normale e patologico, stigmatizzando, escludendo, discriminando…
ma proprio quello che essi stessi scrivono: innescare processi virtuosi, non rinunciare alla gestione della relazione didattica e pedagogica con gli studenti, delegando ai sanitari l’intervento, senza emarginare questi studenti nella classe…
perché la dislessia non è una “malattia”!
È da questo che la Scuola dovrà partire: riappropriarsi del suo ruolo educativo-pedagogico, senza creare confini e discriminazioni, ma ricordando la frase di Don Lorenzo Milani: “Non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far parti uguali fra disuguali.”